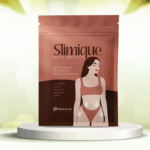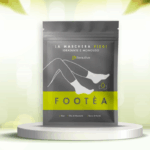Nei reparti ospedalieri, la scelta e l’utilizzo dei disinfettanti non sono lasciati al caso: vengono adottati prodotti selezionati in base a rigorose valutazioni scientifiche, criteri di sicurezza e normative nazionali ed europee. Questa attenzione deriva dalla necessità di prevenire la diffusione di infezioni e garantire un ambiente sicuro a pazienti, operatori e visitatori. I disinfettanti usati negli ospedali appartengono a categorie ben definite, ognuna dotata di specifiche caratteristiche che le rendono efficaci contro determinati microorganismi e adatte a diverse superfici o dispositivi medici.
I principali principi attivi utilizzati
Le sostanze disinfettanti più impiegate in ambito ospedaliero includono:
- Alcooli (in particolare etanolo e isopropanolo): usati in concentrazioni tra il 60% e il 90%, sono efficaci nella disinfezione preventiva di superfici e mani. La loro azione battericida si deve alla capacità di denaturare le proteine microbiche, e risulta ottimale solo in presenza di una quota adeguata di acqua. Sono tra i prodotti più diffusi per la sanificazione rapida di strumenti, dispositivi e aree di lavoro.
- Ipoclorito di sodio: noto anche come candeggina, viene utilizzato prevalentemente per la sanificazione delle superfici ambientali come pavimenti, piani di lavoro e servizi igienici. Viene impiegato a concentrazioni tra lo 0,1% e lo 0,5%, dimostrandosi particolarmente efficace contro virus a involucro (incluso il SARS-CoV-2) e molti batteri patogeni.
- Perossido di idrogeno (acqua ossigenata): utilizzato come liquido o in forma vaporizzata per la disinfezione di superfici, pavimenti, e materiali sensibili agli alogeni. A concentrazioni intorno allo 0,5% garantisce una buona efficacia anche contro virus e spore.
- Sali quaternari d’ammonio: frequentemente associati in formulazioni pronte all’uso per la pulizia rapida di superfici (come nelle salviette disinfettanti), si caratterizzano per una spiccata azione contro batteri e funghi. Alcuni prodotti integrano questi sali con enzimi per incrementarne l’efficacia su materiali organici e residui biologici.
- Clorexidina e altri composti fenolici: spesso utilizzati per la disinfezione della cute e delle mucose, in concentrazione sicura per uso umano, garantiscono un’azione prolungata senza irritare i tessuti.
- Povidone-iodio (PVP-iodio): ideale soprattutto per l’antisepsi della cute prima degli interventi chirurgici grazie al suo spettro di azione molto ampio.
Normative, regolamenti e procedure ospedaliere
L’impiego di disinfettanti negli ospedali è strettamente regolato: ogni prodotto destinato a vantare un’azione battericida, virucida o fungicida deve essere espressamente autorizzato dal Ministero della Salute e rispondere a rigorose normative comunitarie. Si distingue tra:
- Presidi medico-chirurgici (PMC), regolamentati in Italia dal DPR 392/98;
- Biocidi, soggetti al Regolamento europeo (UE) n. 528/2012.
Per i disinfettanti destinati ai dispositivi medici, come le salviette specifiche per strumenti e superfici a contatto con il paziente, è richiesta anche la certificazione CE e la registrazione come dispositivi medici almeno di classe IIa.
Valutazione dell’efficacia
Affinché un prodotto possa essere definito “disinfettante” in ambito sanitario, deve superare test di efficacia su microrganismi standard, principalmente Staphylococcus aureus, Escherichia hirae e Pseudomonas aeruginosa. Tuttavia, questa valutazione non copre tutti i rischi: molti patogeni emergenti o multiresistenti diffusi negli ospedali non sono compresi nei test di routine, rendendo fondamentale aggiornare periodicamente le linee guida e selezionare prodotti efficaci anche contro microrganismi come Candida auris e Acinetobacter baumannii.
Disinfezione mirata: superfici, strumenti e cute
La disinfezione ospedaliera non segue un approccio unico, ma si adatta a diversi contesti e materiali:
- Superfici ambientali: pavimenti, pareti, banchi, e tutte le aree comuni vengono trattati principalmente con ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno e, per azioni rapide tra un paziente e l’altro, con soluzioni idroalcoliche o salviette a base di ammonio quaternario.
- Strumenti chirurgici e dispositivi medici: la pulizia prevede più fasi, dalla detersione con detergenti enzimatici a basso residuo fino alla disinfezione ad alto livello (spesso tramite prodotti a base di sali d’ammonio o ipoclorito a concentrazioni elevate), prima di eventuale sterilizzazione a caldo o a freddo.
- Cute e mani: la disinfezione delle mani del personale è affidata a gel e soluzioni idroalcoliche; per la preparazione cutanea pre-intervento vengono scelti clorexidina o povidone-iodio, con valutazione accurata di eventuali allergie. Questa distinzione tra antisepsi e disinfezione è cruciale in ambito clinico.
Selezione, qualità e rischi nell’uso dei disinfettanti
Ogni ospedale dispone di un rigoroso protocollo per la scelta e l’utilizzo dei prodotti disinfettanti. Si richiede la tracciabilità di tutti i prodotti impiegati, la formazione del personale e, per i fornitori, l’adozione di sistemi avanzati di filtrazione e controlli di qualità che prevengano la contaminazione interna del prodotto.
Un uso improprio dei disinfettanti può comportare rischi per la salute: alcuni principi attivi, se non maneggiati correttamente o usati in concentrazioni eccessive, possono indurre irritazioni, tossicità acuta o cronica a carico di personale e pazienti. Per questo si raccomanda sempre l’impiego esclusivo di formulazioni certificate, testate e dichiarate idonee all’uso sanitario.
In sintesi, in ambiente ospedaliero, la sanificazione e la disinfezione sono affidate a prodotti specifici, autorizzati e utilizzati secondo linee guida aggiornate che comprendono regole sulla scelta dei principi attivi, sui metodi di impiego e sull’attenzione costante verso l’emergere di nuove infezioni. Si tratta di una strategia integrata che pone la sicurezza al centro di ogni attività, garantendo ambienti controllati per la tutela della salute pubblica.