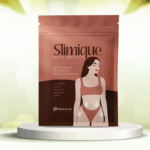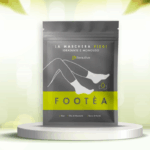I detersivi per i piatti sono il risultato di una formulazione chimica complessa, studiata per garantire efficacia nella rimozione dello sporco e dei grassi, ma anche per risultare maneggevole, gradevole e sicuro da utilizzare quotidianamente. Tuttavia, la loro composizione cela una varietà di sostanze chimiche, alcune delle quali possono destare preoccupazioni per la salute e per l’ambiente. Esaminare cosa contiene davvero un normale detersivo per piatti, quindi, si rivela fondamentale per compiere scelte più consapevoli.
I principali ingredienti alla base della formula
Gli ingredienti fondamentali nei detersivi per piatti appartengono a diverse categorie chimiche, ognuna con un ruolo ben preciso:
- Tensioattivi: rappresentano l’elemento chiave per la rimozione di grassi e oli. La loro struttura anfifilica consente di catturare le molecole di sporco e facilitarne l’eliminazione con l’acqua. Si usano tutto l’anno principalmente tensioattivi anionici per la loro efficacia, ma sono spesso impiegati anche tensioattivi non ionici (per migliorare la tollerabilità sulla pelle) e, in minore quantità, tensioattivi anfoteri, utili per regolare la viscosità e aumentare la schiuma.
- Enzimi: alcune formulazioni, soprattutto quelle con promessa “ecologica” o ad alta efficacia, prevedono enzimi specifici che agiscono sui residui organici, scomponendo particelle di proteine e grassi e facilitando le operazioni di pulizia.
- Bicarbonato di sodio e sali: vengono aggiunti per conferire capacità tamponanti e per aumentare l’azione sgrassante e neutralizzare gli odori persistenti. Sono anche delicatamente abrasivi, migliorando la pulizia delle superfici.
- Acidi organici (es. acido citrico) e aceto: funzionano come anticalcare e aiutano a ottenere stoviglie brillanti, intervenendo sulla durezza dell’acqua e ostacolando la formazione di macchie di calcare.
Sostanze chimiche critiche e potenzialmente nocive
L’efficacia di questi prodotti, tuttavia, si accompagna spesso alla presenza di additivi sintetici che hanno il compito di migliorarne conservabilità, aspetto e profumazione. Alcuni di questi possono rappresentare un rischio per la salute, sia per chi li usa sia per l’ambiente:
- Sodium Laureth Sulfate (SLES): tensioattivo tra i più diffusi, fondamentale per schiuma e potere lavante, ma di origine prevalentemente petrolifera. Può essere irritante per la pelle sensibile e ha una biodegradabilità limitata.
- PEG e PPG (es. PPG-5-laureth-5): polietilenglicoli e polipropilenglicoli sono usati per migliorare la texture e la solubilità, ma la loro scarsa biodegradabilità li rende problematici per l’ambiente. Molti disciplinari ecologici ne limitano fortemente l’uso.
- Coloranti e profumi sintetici: apportano esclusivamente valore estetico, non migliorando in alcun modo l’efficacia. Sono però tra le principali cause di irritazioni cutanee e allergie, sia per chi usa frequentemente il prodotto sia per chi entra in contatto con i residui sulle stoviglie.
- Conservanti come Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone: spesso presenti nella lista ingredienti, impediscono la proliferazione di batteri nel flacone ma sono noti per effetti allergizzanti e pericolosa scarsa biodegradabilità.
- DMDM Hydantoin: liberatore di formaldeide, usato come conservante, potenzialmente tossico e da evitare in caso di sensibilità ai derivati della formaldeide.
Componenti “invisibili”: rischi per salute e ambiente
Non tutti i rischi posti dai detersivi per piatti sono immediatamente percepibili. Alcuni residui di sostanze chimiche rimangono sulle stoviglie nonostante il risciacquo, con potenziale trasferimento negli alimenti. Questo rischia di avvenire soprattutto se si utilizza un detersivo non adatto al lavaggio a mano (ad esempio, quello per lavastoviglie, che ha formulazioni più aggressive pensate per essere completamente diluite e rimosse dal getto potente della macchina).
L’uso prolungato di queste sostanze può comportare:
- Irritazione cutanea a mani e polsi, soprattutto per chi lava spesso i piatti senza guanti.
- Risposta allergica o sensibilizzazione attribuibile a coloranti, profumi o alcuni conservanti.
- Persistenza ambientale sotto forma di microinquinanti, in particolare per alcune categorie di tensioattivi e additivi non biodegradabili, che possono accumularsi nelle acque reflue e influire negativamente sugli ecosistemi acquatici.
La scelta del prodotto giusto, quindi, non è solo una questione di efficienza pulente ma di attenzione verso la sicurezza personale e la sostenibilità ambientale.
Verso una scelta più consapevole: leggere l’etichetta e i disciplinari ecologici
Per ridurre rischi e impatti dei detersivi per piatti, è fondamentale imparare a leggere con attenzione l’etichetta e cercare prodotti certificati da enti terzi. I disciplinari ecologici come Ecolabel impongono limiti severi all’uso di tensioattivi petrolchimici, PEG, PPG, conservanti a rischio e additivi innecessari. Più attenzione meritano anche i detersivi dichiaratamente biodegradabili e privi di profumi sintetici, che riducono la probabilità di equivalenti allergici e di danni agli ambienti acquatici.
Cosa considerare prima di acquistare:
- Prediligere formulazioni con tensioattivi di origine vegetale, meglio se chiaramente indicati sull’etichetta.
- Limitare l’esposizione a profumazioni e coloranti sintetici, optando per prodotti che ne sono privi o che usano solo oli essenziali di qualità.
- Evitare PEG, PPG e conservanti ad alto rischio allergico, prestando attenzione alla presenza di sostanze con suffissi “-eth” o diciture come methylisothiazolinone e affini.
- Scegliere prodotti con certificazioni indipendenti sulla biodegradabilità e sull’assenza di componenti pericolosi per la salute.
Attenzione quindi: nella scelta del detergente per piatti bisogna valutare non solo il potere sgrassante ma anche l’impatto sulla salute e sull’ambiente delle varie componenti. Quanto più breve e “leggibile” sarà la lista degli ingredienti, tanto migliore sarà la sicurezza complessiva per consumatori e natura.